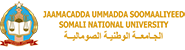Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 66 del 26 marzo 2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., sollevate dal GIP del Tribunale di Milano.
Le censure riguardavano il profilo di compatibilità della norma con gli articoli 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione — quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo — nella parte in cui prevede la punibilità di chi agevola il suicidio altrui, anche nella forma dell’aiuto al suicidio medicalmente assistito, nei confronti di una persona affetta da una patologia irreversibile, non mantenuta in vita tramite trattamenti di sostegno vitale.
Il Giudice a quo era stato chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti di un soggetto indagato in due procedimenti penali riuniti, per aver agevolato il suicidio di due persone affette da patologie irreversibili, causa di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili.
Entrambi i pazienti avevano autonomamente e consapevolmente deciso di rifiutare le terapie indicate dai medici, sapendo che nessun trattamento avrebbe in alcun modo potuto migliorare le loro condizioni. Avevano, quindi, preso contatto con l’odierno indagato, il quale si era reso disponibile ad accompagnarli in strutture svizzere ove erano deceduti per auto somministrazione di un farmaco letale.
Per entrambe le vicende, le indagini preliminari erano state avviate a seguito di autodenuncia dello stesso indagato; successivamente il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di archiviazione, considerando entrambi gli eventi rientranti nell’alveo della non punibilità, così come delineata nella sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019.
Quest’ultima, infatti, ha stabilito che il suicidio assistito può considerarsi legittimo qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) l’irreversibilità della patologia, b) la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili, c) la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, d) la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale (TSV).
Il Giudice a quo, nel caso di specie, ha riconosciuto la sussistenza dei primi tre requisiti, rilevando tuttavia l’assenza del quarto, ovverosia la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. In entrambi i casi, infatti, «all’atto dell’esecuzione della condotta incriminata, nessuna delle due persone offese dipendeva da un trattamento sanitario vitale». Pertanto, il Rimettente ha ritenuto che la condotta tenuta dall’odierno indagato fosse riconducibile alla fattispecie punitiva sancita dall’art. 580 c.p.
Tra i motivi di censura richiamati nell’ordinanza di rimessione, è stata dedotta la violazione dell’art. 3 Cost. Si è evidenziata, infatti, un’irragionevole e discriminatoria disparità di trattamento tra chi agevola il suicidio di una persona sottoposta a un trattamento sanitario di sostegno vitale e ne chiede l’interruzione – condotta rientrante nell’alveo della causa di non punibilità – e chi compie la medesima condotta nei confronti di una persona che rifiuta un trattamento sanitario proposto ma mai intrapreso.
«Nel caso di specie», spiegano i consulenti tecnici del pubblico ministero, «i trattamenti proposti sarebbero stati inutili, poiché la loro attivazione non avrebbe provocato un efficace contrasto alla patologia e la morte sarebbe comunque sopraggiunta inesorabilmente, con l’aggravio di generare ai pazienti, per effetto dell’avvio dei trattamenti, atroci sofferenze così da rendere gli ultimi giorni di vita infernali».
Ulteriori profili di censura dell’art. 580 c.p. sono stati prospettati in riferimento agli artt. 2, 13 e 32 comma 2 Cost., poiché l’esercizio del diritto di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche verrebbe fortemente limitato, fornendo al paziente un’unica modalità di congedo dalla vita, consistente nell’inizio del suddetto trattamento, seppur considerato inutile, al solo fine di interromperlo. Sicché il rifiuto dei trattamenti, delle cure palliative e della sedazione profonda, implicherebbe che egli sarebbe lasciato ad attendere la morte senza alcuna tutela per la propria dignità umana.
Infine è stata dedotta la violazione dell’art. 117 primo comma Cost. con riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU. Il Rimettente rileva infatti che, una volta ammessa dalla normativa italiana la liceità del suicidio medicalmente assistito, nei limiti indicati, questo dovrebbe essere assicurato a tutti i malati che si trovino nelle medesime condizioni, senza alcuna discriminazione. Per concludere, il requisito della dipendenza dai suddetti trattamenti non solo determinerebbe un’ingiusta discriminazione, ma darebbe luogo ad un’ingiustificata ingerenza da parte dello Stato rispetto al diritto di autodeterminazione.
Preliminarmente, la Corte costituzionale, richiamando quanto già affermato nella sentenza 135 del 2024, ha sottolineato il diritto di ogni paziente non solo di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ma anche di rifiutare ab origine l’attivazione dei trattamenti stessi. Sul punto, è stato chiarito che non vi è alcuna distinzione, da un punto di vista costituzionale, tra la situazione del paziente già sottoposto ai suddetti trattamenti, che ne chieda la loro interruzione e quello che necessiti dell’attivazione degli stessi, pur potendo rifiutarli. «Sarebbe peraltro paradossale» – afferma la Corte – «che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale, solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volontà quella di accedere al suicidio assistito». In base a quanto stabilito nella sentenza in commento, dunque, il paziente può rifiutare i trattamenti di sostegno vitale al fine di accedere al suicidio assistito, qualora tuttavia sussistano tutti i requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019.
Nel caso di specie, dunque, il Giudice a quo dovrà valutare, in entrambi i casi sottoposti alla sua attenzione, la sussistenza di tutti i requisiti prescritti.
Ciò premesso, la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte per le stesse regioni di cui alla precedente pronuncia del 2024. Per quanto attiene all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., la Corte ritiene che la lamentata disparità di disciplina tra il paziente che abbia interrotto il trattamento e il paziente che lo abbia rifiutato ab origine non sussista. A ben vedere, il paziente a cui sia stato indicato un trattamento necessario per l’espletamento delle funzioni vitali, ha diritto di esprimere il suo rifiuto e già questa condizione consentirebbe l’accesso al suicidio assistito.
Qualora il paziente decida invece di rifiutare trattamenti terapeutici o palliativi non idonei ad assicurare l’espletamento delle funzioni vitali, la diversità di disciplina per l’accesso al suicidio assistito pare giustificata. La Consulta ha pertanto ribadito «in assenza di un trattamento di sostegno vitale in atto, o almeno di una indicazione medica relativa alla necessità di attivare un simile trattamento, il paziente non si trova ancora nella condizione di poter optare per la propria morte».
Per quanto riguarda l’asserita violazione degli artt. 2, 3 e 32 secondo comma Cost., relativi al diritto di autodeterminazione, la Corte ha chiarito che l’argomento è viziato alla radice in conseguenza di un erroneo presupposto: non è infatti affatto necessario, ai fini del suicidio assistito, che il paziente inizi il trattamento di sostegno vitale per poi interromperlo.
La sentenza ribadisce che, in assenza di una indicazione medica che consideri necessario un trattamento di sostegno vitale, tale condizione non può essere forzatamente imposta al paziente come strada obbligata per esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione.
La Corte richiama inoltre la sentenza n. 135 del 2024, sottolineando che spetta al legislatore bilanciare, con un ampio margine di discrezionalità, da un lato il dovere di tutela della vita umana (art. 2 Cost.) e dall’altro il principio di autonomia del paziente, intesa come espressione del più ampio diritto al libero sviluppo della persona.
In sostanza, la Corte afferma che la Costituzione non impone, ma neppure vieta una disciplina più ampia del suicidio assistito, estesa anche a pazienti non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, purché il legislatore garantisca strumenti efficaci per prevenire abusi e forme di abbandono terapeutico.
La Consulta ha infine dichiarato non fondate le questioni relative all’asserita violazione dell’art. 117, primo comma cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, «nella misura in cui assumono a presupposto l’impossibilità di equiparare l’effettiva sottoposizione a un trattamento medico di sostegno vitale al rifiuto dello stesso, pur in assenza di una valutazione medica relativa alla sua necessità nel caso concreto».
In altre parole, la differenza tra essere effettivamente sottoposti a un trattamento e rifiutarlo dopo l’inizio, da un lato, e il semplice rifiuto prima dell’avvio, dall’altro, è significativa e giustifica un diverso trattamento normativo, anche alla luce della giurisprudenza CEDU.
Per queste ragioni la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni sollevate.
Nella parte conclusiva, la Corte ha ribadito l’importanza delle condizioni sostanziali e procedurali per l’accesso al suicidio assistito, già delineate nella propria giurisprudenza, sottolineando i rischi che l’ordinamento ha il dovere di prevenire, soprattutto in assenza di una disciplina legislativa organica.
In particolare, la Consulta ha evidenziato il pericolo che persone vulnerabili, affette da fragilità psicologiche, malattie o depressione, possano essere spinte a scelte irreversibili in contesti privi di adeguate garanzie, magari anche a causa di pressioni esterne o interessi altrui. Di qui l’importanza di un rigoroso percorso medicalizzato, che comprenda:
a) una valutazione medica seria e approfondita della patologia e del quadro clinico complessivo;
b) l’accesso effettivo alle cure palliative, come prerequisito di ogni scelta consapevole;
c) il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, per garantire un accertamento disinteressato e oggettivo dei requisiti;
d) il parere del comitato etico territorialmente competente, come elemento di controllo terzo e imparziale.
La Corte ha inoltre richiamato l’attenzione sul rischio di derive culturali e sociali, che potrebbero indurre le persone più fragili a percepirsi come un peso per gli altri, alimentando pressioni indirette verso l’autosoppressione. In tale contesto, ha riaffermato il dovere delle istituzioni di garantire un adeguato supporto familiare, sociale e sanitario, anche attraverso l’assistenza domiciliare continuativa. In conclusione, la Corte ha rinnovato l’invito al legislatore e al Servizio sanitario nazionale affinché diano concreta attuazione a quanto stabilito con la sentenza n. 242 del 2019, pur riconoscendo al legislatore la facoltà di adottare una diversa disciplina, purché rispettosa delle garanzie costituzionali e dei princìpi richiamati nella presente pronuncia.
Scarica il testo della sentenza in formato PDF